Guerra dei chip, la Cina minaccia strette su gallio e germanio
pubblicato:Controlli cinesi su gallio e germanio. Si moltiplicano le reazioni cinesi alla politica USA contro la fornitura di tecnologia occidentale alla Repubblica Popolare. Dopo i casi di Huawei, Micron e ASML, l’Europa rischia sempre di più di fare la fine del vaso di coccio. E la sicurezza delle forniture di materiali critici per l’industria diventa sempre più a rischio
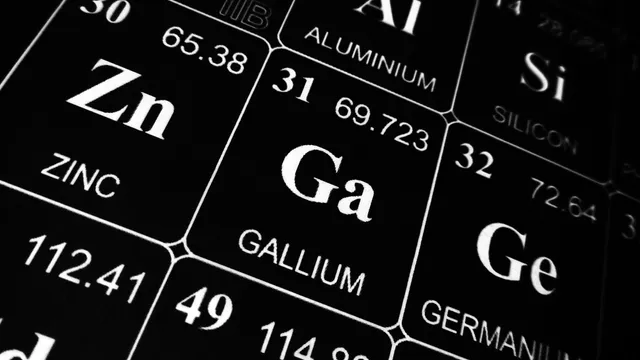
La guerra dei chip è all’escalation e l’Europa si schiera con gli Stati Uniti, malvolentieri, ma sempre più chiaramente.
Come noto Washington e Beijing da molto tempo si fronteggiano in una contrapposizione per il dominio sulle tecnologie strategiche.
Taiwan è forse l’esempio più noto di questo contrasto, visto il dominio della locale TSMC nel mercato globale dei chip, ma il conflitto va ben oltre e il tentativo dell’Europa di sfilarsi da una polarizzazione sempre più accesa sembra fallire ogni giorno di più.
Fra quanto tempo STM o Infineon bloccheranno o ridurranno le vendite al mercato cinese?
USA, una lunga guerra per il dominio tecnologico
In realtà già da prima di Trump gli Stati Uniti hanno guardato con sospetto e ostacolato con sistemi più o meno trasparenti e palesi lo sviluppo tecnologico cinese. Il dominio globale economico e non solo degli States è d’altronde fondato sulla tecnologia da decenni. Microsoft, Apple, Google, Nvidia, Facebook e così via sono da tempo i signori dell’universo e ogni sfida è intollerabile per l’immagine e per il portafoglio dell’ecodominio digitale a stelle e strisce.
Non a casa la parola d’ordine più naturale è parsa, già a Donald Trump, sicurezza nazionale.
Era il maggio del 2019 quando The Donald firmava un decreto per bloccare le tecnologie di Huawei e ZTE negli Stati Uniti.
A molti parve l’ennesima guerra commerciale che cerca di bloccare con leggi nazionali e pressioni tra gli alleati l’emersione di un pericoloso concorrente. Senz’altro tutto questo è vero e anche più verosimile di un concreto timore per la sicurezza nazionale.
Ma in realtà questa strategia di scontro con le tecnologie cinesi era già allora soltanto un passaggio di una strategia economico-politica di lungo periodo.
Era l’agosto del 2018 quando un giudice del Distretto Est di New York emanava un mandato di arresto per la CFO di Huawei Menq Whanzhou, che poi è la figlia di Ren Zhengfei che di Huawei è il fondatore.
L’accusa? Meng avrebbe utilizzato la controllata di Huawei Skycom per fare affari con l’Iran in violazione delle sanzioni USA.
Passano pochi mesi e il primo dicembre 2018 Meng Wanzhou viene arrestata dalla polizia canadese all’aeroporto di Vancouver. Casualmente dopo 9 giorni un ex diplomatico e un imprenditore canadese vengono arrestati per spionaggio in Cina.
A Meng vengono concessi i domiciliari, il caso diventa politico anche in Canada. Gli Stati Uniti chiedono l’estradizione e accusano Meng di frode e cospirazione (avrebbe imbrogliato HSBC sui suoi rapporti con Skycom), ma dopo quattro anni di polemiche sul caso, lo scorso dicembre le accuse USA sono definitivamente cadute, e la manager è potuta tornare in Cina.
In realtà già nell’ottobre del 2012 un report al Congresso da parte della Permanent Select Committee on Intelligence (HSPCI) denunciava il pericolo di una minaccia alla sicurezza nazionale posto dalle società di telecomunicazione cinesi Huawei e ZTE.
Sotto attacco il dominio, più o meno dichiarato, dello Stato cinese sulle due imprese e il timore che questo si traducesse in una deviazione verso scopi geopolitici delle loro attività negli States.
Venivano nel report accennati un po’ fumosamente rischi di backdoor e altri elementi inattesi nei dispositivi, ma soprattutto si paventava il rischio che il finanziamento pubblico di queste imprese minasse la concorrenza e si denunciavano come oscure e opache le risposte sulla governance delle imprese alle domande degli inquirenti.
Da allora le cose sono andate a peggiorare e gli Stati Uniti, nonostante il passaggio dall’amministrazione dei Repubblicani a quella dei Democratici, non hanno mai smesso di aumentare la morsa contro la tecnologia cinese, dapprima focalizzata sulle telecomunicazioni, poi gradualmente estesa ad altri comparti e altri livelli della filiera del tech.
Chip, dalla shortage al reshoring, passando per i finanziamenti pubblici
Le tensioni sono salite e la chip shortage seguita alla pandemia ha dato l’alibi a diversi governi occidentali per programmare e finanziarie un reshoring di produzioni tecnologiche che per decenni sono state asiatiche. Dire che si tratta di gestione del rischio economico sulle filiere rende lo scontro commerciale meno diretto rispetto alle accuse di pericoli per la sicurezza nazionale, ma la sostanza non cambia e per l’Europa anzi il posizionamento si complica.
In Europa nel febbraio del 2022 viene approvato il Chips Act da 43 miliardi di euro per finanziare un ritorno della produzione di chip nel Vecchio Continente, dopo decenni di delocalizzazioni.
E' una risposta che però, già fragile in partenza, sfocia nell'effimero di fronte ai 280 miliardi di dollari del CHIPS and Science Act messi in campo presidente statunitense Joe Biden nell’agosto del 2022.
Certo il Chips Act investe nella produzione di semiconduttori “solo” 52,7 miliardi di dollari, ma aggiunge al pacchetto 24 miliardi di crediti fiscali per la produzione di chip e calcola sicuri effetti positivi dai rimanenti 200 miliardi per ricerca e marketing.
Chip: gli Stati Uniti aumentano le pressioni sulla Cina
Di lì a poco, nell’ottobre 2022, la Casa Bianca blocca la vendita di macchinari per la produzione di chip e l’advanced computing alla Repubblica Popolare, pena la perdita dei finanziamenti pubblici USA.
Il concetto è chiaro, anche la produzione dei chip è strategica e deve essere rinazionalizzata o riportata in giurisdizioni più vicine (nearshoring) o ritenute più “amiche” (il friend-shoring).
Di lì a poco scioperi negli stabilimenti cinesi di Foxconn spingono Apple a premere per un allargamento della produzione anche all’India, ovviamente ci andranno Foxconn e gli altri fornitori, ma è anche l’occasione per lanciarsi su un nuovo promettente mercato.
Ma è palese che l’intera industria tecnologica globale sta cercando di trovare un difficile equilibrio tra esigenze commerciali e produttive e crescenti polarizzazioni geopolitiche.
Piano piano, anche per via delle contrapposizioni in Ucraina e nonostante prove di dialogo sempre seguite da smentite e ritrattamenti, le posizioni tra Cina e USA si divaricano e la Repubblica Popolare si compatta in concomitanza con il rafforzamento del potere interno in mano a Xi Jinping che, terminate le tensioni della politica zero-Covid, intende affrontare le questioni globali della Cina.
Lo scorso marzo si vede la riorganizzazione più ampia dell’ultimo decennio nella nomenclatura cinese. La risposta all’Occidente è decisa.
L’analista dell’Istituto Mercator Nis Grunberg commenta:
“La ristrutturazione amministrativa istituzionalizzerà ulteriormente il ruolo del Partito Comunista Cinese nel coordinamento delle strategie, con aree come la politica finanziaria e della sicurezza nazionale, in particolare, sottoposte a un guinzaglio più stretto”.
Cominciano le reazioni decise della Repubblica Popolare ai crescenti paletti occidentali.
Nel maggio 2023 la Cina blocca la vendita dei prodotti della statunitense Micron alle infrastrutture informatiche del Paese. È uno shock, Micron realizza un quarto del fatturato nel Paese e rischia come tante industrie del settore, uno scenario loss-loss.
D’altro canto la pressione USA si è da tempo allargata agli alleati: a gennaio 2023, dopo una forte pressione USA, Olanda e Giappone siglano un accordo con Washington ai danni di Beijing.
In pratica il colosso europeo dei chip ASML, l’unica al mondo con la tecnologia della litografia a raggi ultravioletti per chip, annuncia che non venderà più in Cina i suoi dispositivi più avanzati. In Cina ASML ha realizzato circa il 15% del proprio fatturato nel 2022.
Decisioni simili impatteranno in Giappone su società come Nikon e Tokyo Electron.
Chip, una guerra di filiera
Ma nel frattempo ci si è accorti che non basta fare guerra a questo o quel brand della Repubblica Popolare, la Cina ha una presenza pervasiva nella filiera, lavora il 90% delle terre rare mondiali. Ma le terre rare non sono certo l’unica materia prima che alla fine viene lavorata in Cina prima di finire nella tecnologia globale.
Così si arriva alle pagine dei giorni di oggi, in cui fa capolino un’altra reazione cinese: controlli sulle esportazioni di germanio e gallio, due materie prime ritenute critiche nella tecnologia dei semiconduttori e nella transizione green. La Cina controlla l’80% del gallio mondiale e produce il 60% del germanio globale.
Il gallio è impiegato proprio nella produzione di circuiti integrati e semiconduttori, ma anche nei LED, mentre il germanio viene usato per la fibra ottica e applicazioni nell’elettronica e nelle celle solari.
Dal primo agosto la Cina ne controllerà le esportazioni e passerà al vaglio tutti gli acquirenti stranieri.
Peraltro la notizia è rimbalzata sui mercati proprio mentre si diffondevano i rumors su un incremento delle riserve strategiche cinesi di cobalto da 2 mila e 5 mila tonnellate.
Cresce il nervosismo dunque tra gli operatori.
A marzo l’Europa ha firmato il Critical Raw Materials Act che punta proprio a differenziare le catene di approvvigionamento, ma se le quote cinesi di mercato sono bulgare e i tempi stretti, diventa sempre difficile scongiurare impatti su produzione, sviluppo tecnologico, costi delle imprese.
Con il rischio che ancora una volta sia l’Europa a pagare la bolletta più cara.